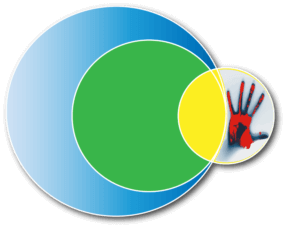Da cosa ha origine questa festa così popolare?
La parola “Halloween” deriva dal termine scozzese “All Hallows’ Eve”, dove “Eve” sta per “even” (poi contratta in “e’en” o “een”), che significa “sera” o “vigilia”, mentre “Hallows” è una parola arcaica per “Saints”, cioè “Santi”: è, in sostanza, la “Vigilia di tutti i Santi”, e corrisponde, praticamente, al nostro “Ognissanti” del 1° Novembre; soltanto che, essendone la vigilia, si svolge la sera prima, il 31 Ottobre. È una festività molto sentita nel mondo anglofono, che ormai ha preso piede anche in Italia e in diversi altri paesi, prevalentemente “occidentali”. Tuttavia, la sua origine è molto antica, risalente al Capodanno celtico, lo “Samhain”, che celebrava il passaggio dalla stagione estiva a quella autunno-invernale, e quindi la fine del raccolto e il suo immagazzinamento come riserva per i duri e freddi giorni a venire; in questo periodo, in cui si passava dalla luce delle lunghe giornate estive al veloce calare delle tenebre autunnali e invernali, si credeva che il confine tra il mondo terreno e l’“Aldilà” si assottigliasse, tanto da permettere alle anime dei defunti (che riposano sotto terra, proprio come i semi piantati in Autunno per l’anno a venire, durante l’Inverno) di oltrepassarlo per andare a trovare i vivi… La cosa era abbastanza inquietante! Per “ingraziarseli”, ed evitare eventuali vendette, la gente preparava del cibo, soprattutto dolci, da offrire loro in caso di visite, nonché delle luci per indicargli la strada di casa, che consistevano in candele racchiuse dentro rape intagliate a questo scopo… Ed ecco spiegati gli stuoli di bambini e ragazzi travestiti da fantasmi, streghe e mostri vari, che la notte di Halloween bussano alle porte delle case, muniti di appositi contenitori, pronunciando la famosa e minacciosa richiesta: “Dolcetto o Scherzetto?” (in inglese: “Trick or Treat?”); le figure impersonate rappresenterebbero gli spiriti “malintenzionati”, per acquietare i quali, ed evitare eventuali brutti scherzi da parte loro, la gente si premura di avere in casa una scorta sufficiente di dolciumi da regalargli… La celebre zucca illuminata all’interno sostituirebbe le primitive rape, poiché, oltre ad essere più grande e quindi più facile da intagliare, è un ortaggio che si trova più facilmente negli Stati Uniti, da dove questa tradizione è giunta fino a noi…Ma come mai proprio da qui, nonostante la sua origine sia celtica? Perché l’Irlanda è diventata la terra che ha ereditato maggiormente questa antica cultura, e quando, a partire dal 1800, molti Irlandesi emigrarono in America, spinti dalla povertà e in cerca di fortuna, portarono con sé queste usanze, che si diffusero poi a una gran parte del mondo occidentale. La zucca, con la sua smorfia ricavata nella scorza e la candela all’interno, si ricollegherebbe anche alla leggenda di “Jack-o’-lantern”: questi era un furbo fabbro irlandese, ubriacone, che riuscì ad ingannare più volte il Diavolo, incontrato una sera in un pub. Cominciò chiedendogli di trasformarsi in una moneta, che gli consentisse un’ultima bevuta prima di consegnargli la sua anima: con la sua astuzia, egli riuscì ad ottenere altri 10 anni di vita, al termine dei quali, però, il Signore delle Tenebre si ripresentò; ma, con un ulteriore stratagemma, Jack riuscì nuovamente ad evitare l’Inferno! Tuttavia, essendo stato in vita un grande peccatore, non gli fu permesso di entrare neanche in Paradiso, e così la sua anima fu costretta a vagare nel mondo dei vivi, scaldandosi e illuminandosi la via con un tizzone ardente lanciatogli dal Diavolo per scacciarlo dall’Inferno. La zucca-lanterna posta fuori dalle soglie delle case gli indicherebbe che lì non c’è posto per lui…
Simili usanze, concernenti il legame tra il mondo dei vivi e quello dei morti, in cui s’intrecciano antichi elementi pagani e cristiani, si riscontrano anche in varie zone d’Italia, e sono spesso caratterizzate dalla preparazione dei cosiddetti “Dolci dell’Anima”: le “fave dolci” o, appunto, “fave dei morti”, in Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, e Umbria; le “ossa di morto”, sorta di biscotti oblunghi con questa forma, e poi la “puppacena” e la “martorana” in Sicilia; “o’ morticiello” a Napoli, goloso torrone glassato con cioccolato; “i papassinos”, dolcetti di pastafrolla con uva passa, mandorle, noci e spezie, che i ragazzini mascherati richiedono di casa in casa in Sardegna, esclamando: “sòe su mortu mortu!”…
Insomma, nonostante oggi molte sue manifestazioni “scadano” nel commerciale, la permanenza in molti luoghi di tradizioni antiche legate a questa festa rivela, forse, il bisogno ancestrale e comune di noi esseri umani di ricordare i nostri cari scomparsi dalla vita terrena, nonché di esorcizzare la morte stessa, potendoli magari incontrare nuovamente su questa terra almeno una volta all’anno, e cioè in questa magica notte, in cui è permesso attraversare quel velo sottile.

Vittoria Montemezzo
Sono nata nel 1977, ho un diploma di liceo linguistico, mi piacciono i bambini, la natura, la storia e le culture antiche…e l’essere umano in generale. Dal 2015 sono insieme ad un compagno disabile in sedia a rotelle.